Riflessione di Fedro, Calvino e i suoi nobili, del 31 ottobre 2025
31 Ottobre 2025 in Post ad hoc, Prima Pagina
Italo Calvino è stato uno degli scrittori italiani più innovativi e influenti del Novecento, capace di rinnovare radicalmente le forme della narrazione grazie a una continua ricerca stilistica e tematica.
Calvino nacque il 15 ottobre 1923 a Santiago de Las Vegas, Cuba, da genitori italiani entrambi impegnati nel mondo scientifico. Nel 1925 la famiglia si trasferì in Liguria, dove Calvino crebbe e maturò i primi interessi letterari. Durante la Seconda guerra mondiale partecipò attivamente alla Resistenza, esperienza che influenzerà profondamente il suo primo romanzo, “Il sentiero dei nidi di ragno” (1947). Dopo la guerra collaborò con la casa editrice Einaudi e iniziò una carriera che lo portò a diventare una delle voci più rappresentative della letteratura italiana. Morì a Siena il 19 settembre 1985.
La traiettoria stilistica di Calvino si snoda attraverso fasi ben distinte, che rispecchiano tanto la sua personale evoluzione quanto i mutamenti della cultura letteraria italiana. Alla fine degli anni ’40, Calvino si inserisce nel filone neorealista, caratterizzato da una narrazione lucida, oggettiva e attenta alla resa della realtà sociale. Opere come “Il sentiero dei nidi di ragno” esprimono il desiderio di raccontare il mondo attraverso lo sguardo ingenuo, ma non per questo meno acuto, dei “piccoli”.
A partire dagli anni ’50, Calvino si sposta verso un registro fantastico e allegorico, rintracciabile nella trilogia “I nostri antenati”, in cui la narrazione si fa metafora delle grandi domande esistenziali, esplorando tematiche come il doppio, l’alienazione, la libertà, l’identità. Parallelamente si affina la tendenza di Calvino alla “leggerezza” della forma, intesa come tensione all’essenzialità, all’ironia e all’esattezza stilistica, temi che saranno alla base delle “Lezioni americane”, il suo testamento letterario.
Negli anni ’60-’70 avviene il passaggio verso una scrittura “combinatoria”, in cui la narrazione diventa un gioco strutturale e il romanzo un dispositivo che esplora le infinite possibilità del linguaggio e della costruzione letteraria. In “Le città invisibili”, “Il castello dei destini incrociati” e “Se una notte d’inverno un viaggiatore”, Calvino mette in scena narrazioni frammentate, polifoniche e labirintiche, capaci di coinvolgere il lettore nel processo stesso della lettura e dell’invenzione.
Tre opere più conosciute
1. Il sentiero dei nidi di ragno (1947)
Romanzo d’esordio, ambientato durante la Resistenza e raccontato dal punto di vista di Pin, un bambino che vive ai margini della società. Attraverso il suo sguardo ingenuo, la narrazione acquisisce una dimensione fiabesca che stempera la durezza degli eventi storici. Il realismo si fonde alla fantasia, offrendo una riflessione su innocenza, esperienza e perdita.
2. Il barone rampante (1957)
Secondo romanzo della trilogia “I nostri antenati”, il libro racconta la storia di Cosimo Piovasco di Rondò, giovane nobile che decide di vivere sugli alberi per il resto della sua vita. La scelta di Cosimo è sia ribellione che ricerca di autonomia, e la narrazione si trasforma in una parabola sulla libertà individuale e sulla necessità di osservare la realtà da una prospettiva distaccata e critica. L’opera si distingue per la leggerezza dello stile, la ricchezza delle invenzioni narrative e la profondità filosofica.
3. Le città invisibili (1972)
Si tratta di uno dei testi più rappresentativi della maturità di Calvino, in cui il protagonista Marco Polo descrive a Kublai Khan una serie di città immaginarie, ciascuna metafora di stati d’animo, idee e visioni del mondo. La struttura interna, basata su giochi combinatori e richiami incrociati, rende il libro una riflessione sulle possibilità della scrittura, sull’identità, sulla memoria e sull’utopia.
Bibliografia
Il percorso letterario di Calvino si apre con “Il sentiero dei nidi di ragno” (1947), cui seguono numerosi racconti come “Ultimo viene il corvo” (1949). Negli anni ’50 si afferma con “Il visconte dimezzato” (1952), “Il barone rampante” (1957) e “Il cavaliere inesistente” (1959), raccolti poi nella trilogia “I nostri antenati” (1960). In questo periodo pubblica anche “La speculazione edilizia” e “La giornata d’uno scrutatore” (1963).
Dagli anni ’60 si affaccia alla narrazione breve con “Marcovaldo” (1963) e con le raccolte di racconti “Gli amori difficili” e “Le cosmicomiche” (1965), dove una prosa ironica e raffinata accompagna la riflessione sulle dinamiche del mondo. Il suo interesse per la struttura del racconto si manifesta nei romanzi successivi, come “Le città invisibili” (1972), “Il castello dei destini incrociati” (1973) e “Se una notte d’inverno un viaggiatore” (1979), caratterizzati da narrazioni sperimentali e giochi di costruzione.
Negli ultimi anni, “Palomar” (1983) incarna il climax della riflessione calviniana sul rapporto tra soggetto e mondo, con una scrittura minima e analitica. L’eredità teorica e poetica di Calvino si coglie infine nelle “Lezioni americane” (1988, postumo), dove lo scrittore espone i cinque valori per la letteratura del futuro: leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità.
La sua produzione comprende anche fiabe e testi saggistici, testimonianza di una incessante curiosità e di una costante voglia di sperimentare nuovi linguaggi, culminata in una bibliografia ampia e variegata, fondamentale per la letteratura italiana e internazionale.
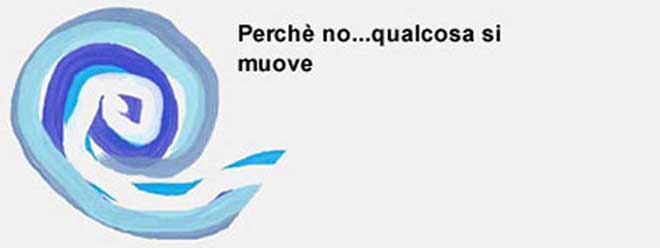


Commenti recenti